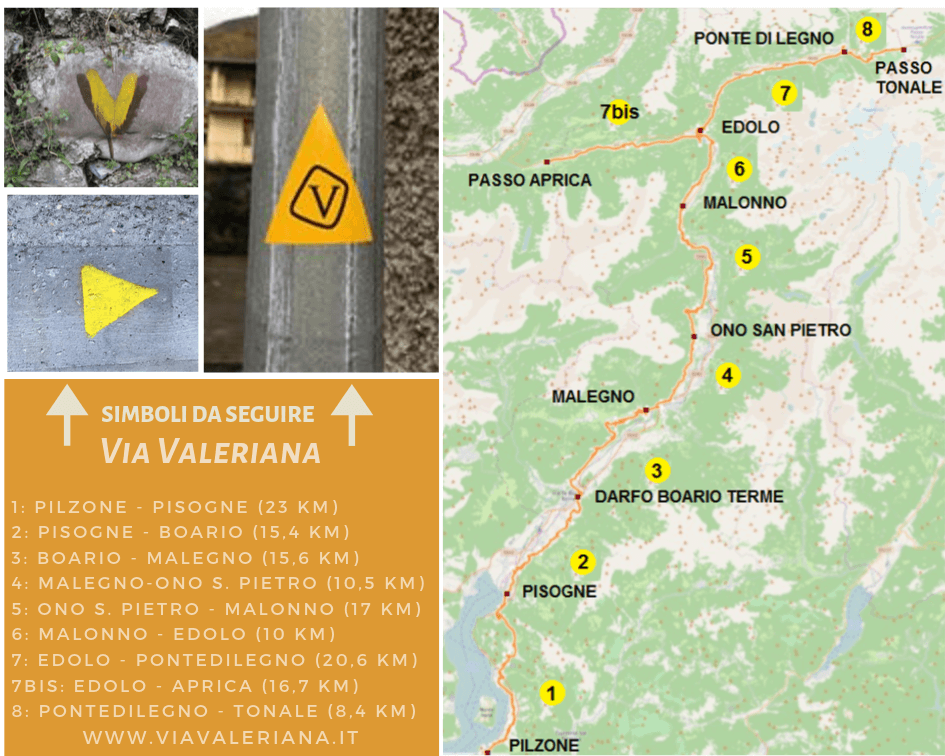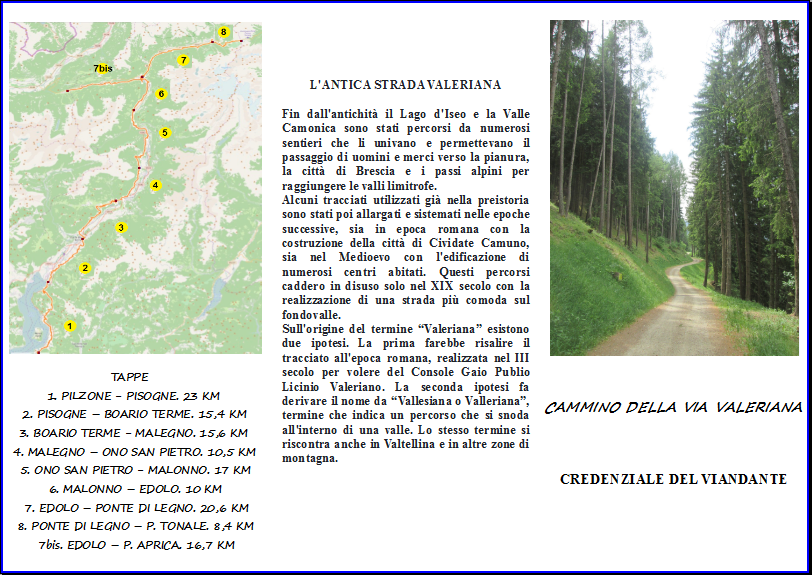Il Santuario della Madonna della Ceriola
Il punto più panoramico di tutta l’Isola
Le origini remote del Santuario della Madonna della Ceriola risalgono circa alla metà del V secolo, quando San Vigilio, Vescovo di Brescia, portò la fede nella zona del Sebino sopprimendo il culto della dea pagana Iside. La fede del Cristo Salvatore si divulgò ben presto e San Vigilio portò devozione anche alla Madre del Cristo: la Madonna.
Pensò, infatti, di fare erigere sulla cima dell’Isola una piccola cappella, dedicandola alla Beata Vergine Maria, come simbolo della purificazione dalle superstizioni pagane e simbolo della nuova luce del Cristianesimo. La piccola chiesa fu la prima parrocchia dell’isola, chiamata “Santa Maria de curis” come appare nel catalogo dei beni della diocesi di Brescia, compilato nel 1410. Inoltre fu anche la prima chiesa del lago dedicata alla Madonna. Successivamente divenne Madonna della Ceriola, probabilmente perché l’effigie della Madonna (XII sec.) venne scolpita in un ceppo di cerro. E’ stata intagliata seduta su di un trono, con un ampio manto, con in braccio il Bambino.
Il 14 marzo del 1580, San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano, passando in visita sulle strade bresciane, mandò il suo convisitatore Don Ottavio Abbiati sull’Isola a visitare il Santuario. Di questa visita stende una relazione in cui scrive:” Santuario ampio e decente, altare unico consacrato, come pure la chiesa, pitture avariate, trittico con la statua della vergine”. Dopo questa visita il rettore della parrocchia, Francesco Augustinelli, ne ordinò il restauro cambiando quasi completamente la struttura originaria. Nell’ ampliamento si costruì un nuovo presbiterio che portò maggior proporzione all’ insieme. Venne posta l’ artistica cancellata in ferro battuto, dividendo così la zona sacra dalla zona riservata ai fedeli. Il vecchio tetto a capanna fu sostituito dalla volta a botte e vennero aperte le due cappelle laterali dove sarebbe stato collocato l’ altare di San Fermo e più tardi la pala raffigurante il Transito di San Giuseppe, realizzata dall’artista bresciano Antonio Paglia nel 1763. I lavori finirono all’inizio del Seicento (come attesta la scritta sull’architrave del portale della facciata “Francesco Augustinelli presbiteris Rettoris Ope 1600”).
Nel 1750 venne radicalmente mutata la facciata con la costruzione, sulla base dell’antichissimo santuario, del massiccio campanile in granito.
Fortunatamente nel 1815, un fulmine scrostò una parte di muro, all’interno della facciata est, evidenziando un affresco in perfetto stato di conservazione, che raffigurava un Cristo Ecce Homo legato con una fune ad una colonna e coronato di spine. Quest’ opera è stata attribuita a Giovanni da Marone.
Nel 1836 in Lombardia si diffuse il colera. Gli abitanti di Monte Isola, disperati per le numerose vittime, si rivolsero alla “loro” Madonna salendo in processione verso il Santuario dove fecero voto di consacrare quella domenica se fosse cessato quel castigo. Da quel giorno la malattia si indebolì fino a scomparire. Da allora, ancora oggi, ogni seconda domenica di luglio si festeggia la venerata Madonna del Colera, in nome della malattia sconfitta.
Il Santuario è lungo 23 metri, largo 7,5 e alto 10, composto da un unica navata e caratterizzato da una volta a botte che poggia su di un cornicione in cotto che corre lungo tutto il perimetro della chiesa, sostenuto da lesene con capitelli in stile Barocco, come il resto dei fregi e degli ornamenti che caratterizzano la volta e la cupola del presbiterio. L’altare maggiore è costruito in marmo nero e bianco e su di esso si innalza una soasa in legno del 1400. La cornice è stata aggiunta nel 1620 ed è costituita da due colonne in stile corinzio che sostengono la trabeazione e il timpano. Il trittico è composto dalla Madonna al centro e dalle statue in legno dorato dei Santi Faustino e Giovita (patroni di Siviano). Sia la Vergine che Gesù Bambino indossano una vecchia corona d’oro. La lunetta sovrastante l’altare maggiore ritrae la Nascita di Gesù, nella cupola sopra il presbiterio è raffigurata la Purificazione di Maria Vergine, mentre i tre medaglioni che ornano la navata ritraggono L’Incoronazione della Madonna, L’Assunta e L’Annunciazione. Una targa in stucco, posta sull’arco trionfale, riporta la scritta che rievoca il mistero a cui è dedicato il Santuario: “Suscepimus Deus Misericordiam Tuam In Medio Templi Tui”.
Lateralmente all’altare maggiore sono situate due cappelle: a sinistra la cappella di S. Fermo, con altare in legno intagliato, risalente al 1600, mentre a destra, la cappella di San Giuseppe con la pala del Paglia. Entrando sulla sinistra si possono ammirare i resti degli affreschi della chiesa precedente, una Madonna col Bambino molto simile alla statua, ordinata probabilmente da una famiglia di cui solo in parte si possono leggere i nomi, perchè manca il resto della bellissima opera, decurtata quando venne aperta una porta per la visita vescovile. Sempre nella parte interna della facciata, sopra la porta, si trova un affresco del 1924 che rappresenta il vescovo San Vigilio, apostolo che portò fede e devozione nel Sebino. Ai lati del presbiterio vi sono due affreschi dell’artista Locatelli (1924), raffiguranti Santa Bartolomea Capitanio, protettrice di Lovere e Sant’Angela Merici. Tra l’altare maggiore e la navata centrale è posta una cancellata in ferro battuto del 1600.
Dedicate sempre alla Madonna, sono le tavolette votive, quadri recenti ed antichi, appesi sul fondo della parete sinistra, chiamati anche “ex voto”. Se ne contano 82, alcuni datati anche 1620, ma i più numerosi sono del 1800. Simboleggiano la devozione e la gratitudine del fedele nei confronti della Madonna. Ancora oggi c’è questa usanza, anche se al posto delle tavolette dipinte, vengono appese delle fotografie. Sono presenti anche molte preghiere dedicate alla Madonna, poesie di Emilia Belli (poetessa del Lago d’Iseo) e canzoni in onore dell’Incoronazione della Madonna, avvenuta il 30 agosto 1924. Durante l’attesa di quel fatidico giorno, i fedeli di Monte Isola, offrirono una parte dei loro averi, fino ad arrivare al peso di un Kg d’oro, permettendo così la fusione di una splendida corona incastonata di pietre preziose per la Madonna ed una per il Bambino.
Oggi il Santuario, giuridicamente nel territorio isolano, è il simbolo dell’ unità civile di tutti i cittadini dell’ unico comune di Monte Isola, che porta nel suo stemma proprio la figura del Santuario della Madonna della Ceriola.
Come arrivare:
– a piedi, da Peschiera Maraglio: il sentiero parte fuori dall’Ufficio Informazioni e si snoda in salita nel paese. Una volta attraversata la strada che sale a Senzano, il sentiero inizia ad inoltrarsi nel bosco. In poco più di un’ora, passando dall’abitato di Cure, sarete al Santuario. Consigliate scarpe da ginnastica comode e chiuse (no sandali, no tacchi).
Dislivello: 450m
Tempo di percorrenza: 80min
Km: 4
Livello: E
– In autobus: il sabato, la domenica e i festivi è attivo un servizio bus (portata di 20 posti) che parte nei pressi del pontile n. 1 di Peschiera Maraglio e ferma nel borgo di Cure dove parte il sentiero che in 20 minuti porta al Santuario. Il servizio è attivo dalle 10.00 alle 18.30 con una corsa ogni 20 minuti circa, al costo di 1,50 euro a persona per viaggio. Nei giorni feriali è attivo il servizio regolare di bus.
Orario funzioni:
– Sabato 10.00
Durante le funzioni le visite sono sospese.